ANATOLIA:
SULLE ORME DI REMOTE CIVILTA’
 |
| Cittadella di Gaziantep |
Partendo da Girne, Cipro turca, con il traghetto si
giunge dopo circa tre ore a Taşucu, piccolo porto con spiaggia a lato, modesta
stazione balneare per un turismo tutto locale: la città di Silifke, l’antica Seleucia,
dista soltanto una decina di km. Fondata dal re di Siria Seleucio I Nicator nel
III secolo a.C., l’odierna Silifke ha ancora numerose rovine che ricordano la
pristina gloria: spezzoni di cinta muraria, un’immensa cisterna bizantina, la
cittadella (la strada sconnessa e deserta mi ha scoraggiato dal raggiungerla) e
ben accessibile in centro il tempio a Giove, del quale sopravvive oltre a
frammenti sparsi una sola colonna intera con capitello corinzio, che al momento
della visita era sovrastata da un paffuto nido di cicogna con inquilina
installata.
 |
| Silifke, Tempio di Giove |
Bello il ponte di pietra sul fiume Göksu (in turco “acqua azzurro
cielo”), dove annegò Federico Barbarossa en route verso la Palestina per la 3°
crociata, il 10 giugno 1190, astutamente tuffandosi per rinfrescarsi con
armatura addosso in acque tumultuose per il recente disgelo a monte.
Sulle montagne del Tauro, a 1100 mt di altitudine e a 30
km da Silifke si trova un sito archeologico tanto affascinante quanto poco
conosciuto dal nome ingrato: Uzuncanburç[1],
dove da un lato si possono ammirare i resti di un acquedotto dell’antica città
romana di Olba, mentre sull’altro versante dell’altura sorgono i resti e le
numerose colonne del tempio greco a Zeus Olbios, preceduto da un ninfeo ben
conservato.
Anche qui parte dell’incanto del luogo è legato alla qualità della
luce sfolgorante di giugno nell’aria limpida, al silenzio rotto dal frinire di
qualche cicala e al panorama montano superbo. Incredibilmente c’è un servizio
pubblico di trasporto di andata e ritorno giornaliero per i contadini del
villaggio e i rari viaggiatori a piedi.
L’ufficio turistico di Silifke, il primo e l’ultimo aperto
e funzionante in ore d’ufficio che troverò in Anatolia, mi aveva rifornito di
dépliant seducenti sulle meraviglie archeologiche visitabili prima di Mersin,
direzione est: il castello di Korykos, Kizcalesi (il castello della fanciulla)
e le grotte dette del paradiso e dell’inferno.
 |
| Particolare, Tempio di Zeus |
Quando avevo già un piede sul
predellino per scendere dall’autobus a Kizcalesi ho dato una rapida occhiata
intorno e ho fatto un balzo indietro per recuperare il sedile: a destra e a sinistra
della strada si assiepavano file compatte di moderni albergacci e spacci di
patatine fritte, e l’unico spiraglio nella muraglia di cemento lasciava
intravvedere una spiaggia con schiere di ombrelloni. Con rammarico ho cambiato
il biglietto e dopo due ore e mezzo interminabili con decine di fermate e
mostri di calcestruzzo schierati a nascondere il mare sono scesa per
esaurimento alla periferia di Mersin, grossa città con importante (e
invisibile) porto commerciale e di trascurabili attrattive. E pensare che la
Mersin arcaica, Yumuktepe (5000 a.C.),
era un importante snodo geo-culturale tra la Mesopotamia a partire dall’antica
Cilicia Pedias – oggi regione di Çukurova – attraverso il passo di Sertavul
nella catena del Tauro verso il Mediterraneo e la Siria settentrionale. Il
suffisso tepe dei toponimi arcaici
turchi indica un rilievo, un tumulo che racchiude reperti archeologici sepolti.
 |
| Sarikeçili in viaggio |
Della odierna Mersin apprezzo soltanto il Museo
archeologico che vanta scenografiche ricostruzioni di tombe intagliate nella roccia[2]
con statue mollemente adagiate su triclini e bei sarcofaghi romani; si proietta
inoltre a getto continuo un filmato molto interessante sull’ultimo esiguo
nucleo di popolazione nomade turca: i Sarikeçili[3],
pastori originari di un villaggio omonimo in provincia di Adana, filmato che
rivedo più volte per coglierne foto eloquenti e toccanti[4].
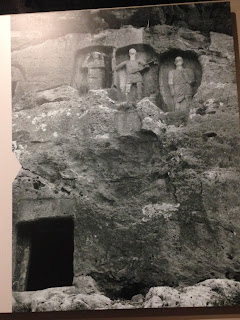 |
| Rock-cut tombs, Museo di Mersin |
Partendo da Mersin sempre diretta a est ho la cattiva
idea di fare una tappa a Tarso, anche se le poche righe della guida dovrebbero
scoraggiarmi, e ho quanto mi merito: l’abitato è banale e il museo che
raggiungo a fatica balbettando dieci volte in turco la stessa domanda sul
cammino da percorrere è chiuso, evidentemente da molto tempo, e mi chiedo per
quale perversità nessuno me lo ha fatto sospettare, dato che “aperto/chiuso”
sono tra i pochi vocaboli turchi che conosco. Introvabile la cosiddetta fontana
di San Paolo.
Dietrofront e treno per Adana: la linea Mersin-Adana è
l’unica connessione ferroviaria del sud Anatolia in funzione. Sorpresa: Adana è
veramente una città interessante e mi è parsa la più aperta al mondo non turco,
la più piacevole anche se difficile da girare a piedi date le distanze e i
lunghi viali pur alberati pulsanti di traffico, l’unica dove riesco a trovare bei
negozi e un ristorante con un’ottima cucina italiana gestita da una coppia
locale, quella cucina italiana che in genere all’estero snobbo ma che questa
volta mi sembra un regalo divino dopo parche cene analcoliche.
E il museo
archeologico è il primo di una serie di musei uno più bello dell’altro, che
sono stati il sale del viaggio e mi hanno fatto capire la differenza tra il vedere
tesori d’arte assira o babilonese al Pergamon di Berlino o al British di Londra
o vederli là dove la civiltà i cui tesori sono esposti si è sviluppata e si è
ahimè spenta. Anche dopo tre o quattro ore di visita non ho mai provato quel senso
di oppressione che mi coglieva al British, che è (o era, non so oggi) gratis e
che visitavo spesso quando studiavo a Londra.
Nelle prime teche ci sono
numerosi sigilli del calcolitico di terracotta, di pietra o anche d’osso,
provenienti dalla Siria e dalla Mesopotamia, risalenti al 7° millennio a. C;
venivano usati in ambito legale per inviare pacchi o lettere. Poi si succedono
straordinarie serie di tavolette d’argilla di pochi centimetri scritte in
finissimi e fittissimi caratteri sumerici cuneiformi, che rappresentano la
prima forma di scrittura intorno al 3500 a.C.
Sono registri contabili di merci
consegnate redatte da funzionari dell’Impero Ittita (1700-1200 circa a.C.) che adottò
la scrittura cuneiforme di origine assira. Le tavolette sono state
dissotterrate a Uruk, nella bassa Mesopotamia, la città del famoso re
Gilgamesh, protagonista dell’epopea omonima[5].
La tavoletta con un brano di questo poema la vedrò nel museo di Şanliurfa.
Imponente la statua del dio Tarhunda, eretto su un cocchio che era trainato da
due tori simboleggianti il giorno e la notte.
 |
| Il dio Tarhunda, Adana |
l giorno successivo parto per Gaziantep, ormai entrando
nell’ex-Mesopotamia - vedere accanto la provvidenziale cartina fornita dal locale museo
archeologico, lo Zeugma Museum - che è uno
scrigno di mezzo km quadrato di mosaici romani magnifici e molto ben conservati,
e pour cause!
Infatti le ville romane dove si trovavano rimasero sepolte per
secoli, finché durante gli scavi per la costruzione della vicina diga Birecik
sul fiume Eufrate vennero alla luce e furono asportati per salvarli dall’inondazione.
Le raffigurazioni sono di una grande eleganza e nettissime: uno dei più famosi
è il dittico di Oceano e Teti, ma sono tutti mosaici stupendi: le tessere sono
minuscole fino a evocare veri e propri quadri, le espressioni dei volti
intense, i colori dei drappeggi sontuosi e cangianti, le membra hanno toni
sfumati e sono piene di movimento; una festa per l’occhio e per lo spirito,
anche se, pensando al lavoro artigianale di migliaia di schiavi curvi a
tagliare prima la pietra e poi le tessere, si riflette ancora una volta sul
sudore e sangue che la bellezza dell’arte spesso sottende.
 | ||
| Oceano e Tei, Gaziantep |
 |
| Museo di Gaziantep |
La Cittadella selgiuchide[6]
che domina Gaziantep su una altura appena fuori del cuore del centro storico è
tutta occupata da un museo inneggiante alla guerra d’indipendenza turca,
immediatamente successiva alla prima guerra mondiale, nella quale L’Impero
Ottomano si era schierato con gli Imperi Centrali. In particolare vi si celebra
la vittoria nella guerra franco-turca (1918/21) combattuta in Cilicia, che vide
la resistenza accanita contro le truppe francesi che difendevano gli interessi
della Francia di tre città soprattutto: Antep, Maraş e Urfa che riuscirono a
respingere il nemico. In seguito alla vittoria il nome delle città cambiò in
Gaziantep, Kahramanmaraş e Şanliurfa, premettendo ai nomi rispettivi gli
aggettivi “reduci”, “eroici” e “gloriosi” in onore dei combattenti. Peccato che
l’ombra dei Giovani Turchi aleggi pesante e che quanto esposto trasudi un
iper-nazionalismo e un militarismo trionfalistici molto fastidiosi, a scapito
di una documentazione storica spassionata chiaramente impossibile, poiché l’identità
nazionale turca si costituì contro le identità greca e armena che pure erano
parte integrante del patrimonio storico e culturale dell’Anatolia occidentale.
A quell’epoca il genocidio armeno (24 aprile 1915/1917) era ormai compiuto[7]
e si preparava quello che i greci chiamano “il genocidio dei greci del Ponto” e
lo strappo sciagurato dello “scambio di popolazioni” con annessa distruzione –e
massacro - di una città cosmopolita con una storia millenaria come Smirne,
l’odierna Izmir[8].
Intristita dall’esaltazione smaccata di un’epoca
relazionata a tali catastrofi, mi rasserena la visita a un antico hamam
trasformato in museo, costruito intorno al 1565. In Anatolia i bagni pubblici
esistevano sin dall’era del bronzo (3600-1200 a.C.) e prendevano come modello
le terme romane con il calidarium, tepidarium e frigidarium. Addirittura prima
del 1000 d.C. anche le popolazioni nomadi facevano il bagno in tende di pelli
chiamate çerge. A tutt’oggi in aree
rurali si fabbrica artigianalmente il sapone con liscivia e olio d’oliva (forse
anche grasso di montone, penso io, memore di una conversazione in Mali con una
collega che come grasso per la confezione di sapone aveva utilizzato i resti
del montone del Tabaski[9]).
C’erano già allora i massaggiatori professionali che usavano ruvidi guanti di
lana di capra chiamati keseler
(plurale di kese). Una vasca speciale
in una stanzetta a parte era riservata al bagno rituale (mikveh) dei clienti ebrei.
Lasciata Gaziantep procedo a est e arrivo a Şanliurfa,
dove vedrò il tempio del neolitico preceramico più antico del mondo[10]
(9600 a.C.) e, non lontano dal tempio, sia la grotta dove secondo la tradizione
(?) nacque Abramo che lo stagno sgorgato dalle fiamme che avrebbero dovuto
bruciarlo (da adulto), quando i carboni ardenti si trasformarono in carpe
guizzanti. Peccato che al mio arrivo il termometro segni 41 gradi C all’ombra.
 |
| Leone di Basalto, Museo di Adana |
[1] La “c”
in turco suona g palatale (gi,ge italiano) e ç come c dolce (cena).
[2] Rock-cut
tombs in inglese, tipiche di molte zone dell’Anatolia, visibili a Dalyan, a
Fethtiye e appunto nella zona di Silifke e Mersin.
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1ke%C3%A7ili,_Ceyhan
[4] https://www.youtube.com/watch?v=rYg9iuTlL3Y
( questa è un’intervista in lingua turca e non il filmato che ho visto nel museo di Mersin, tuttavia è evidente
il contesto pastorale).
[5] Uruk fu
nel 4° millennio una grande città che nel periodo del massimo splendore aveva
ben 80.000 abitanti in 6 km2, forse la più grande del mondo in quel periodo.
[6] http://www.treccani.it/enciclopedia/selgiuchidi/
[7] http://www.comunitaarmena.it/il-genocidio-armeno/
[8] https://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_di_popolazioni_tra_Grecia_e_Turchia
[9] Così si
chiama in Africa Occidentale la festa dell’Eid al-adha, festa del sacrificio
che commemora il sacrificio di Isacco risparmiato all’ultimo momento. Invece
nessuno salva i montoni.
[10] Le
ziqqurat sumere sono datate 5000 anni più tardi.



























